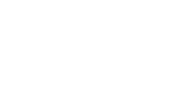Strategie di difesa
I Giallumi della Vite (GY), presenti e dannosi nelle aree vitate reggiane, sono ben due, flavescenza dorata (FD) e legno nero (BN). Pertanto la linea di difesa non può che essere combinata, deve cioè combattere in modo sovrapposto entrambe le pericolose epidemie fitoplasmatiche. La difesa dai Giallumi si compone di prevenzione e di lotta diretta ed indiretta.
PREVENZIONE
Materiale di propagazione sano (barbatelle, talee, marze)
Il materiale di propagazione può essere responsabile dell'introduzione di GY e di scafoideo in una nuova area, mediante barbatelle infette e/o ospiti di uova svernanti. Si è constatato una certa efficacia del trattamento termoterapico nei confronti delle infezioni da fitoplasmi. La termoterapia è utile anche contro vari altri agenti di malattia e di danno quali Phytophthora cinnamomi, Agrobacteriun tumefaciens, Xanthomonas ampelina e i nematodi Xiphinema index e Meloidogyne spp. Vivaisti piemontesi hanno cominciato ad applicare su vasta scala tale tecnica.
Eliminare i focolai d'infezione
Anche i vigneti e i filari di vite abbandonati o non curati possono rappresentare insieme alle viti spontanee lungo le strade, le carraie, ecc., sacche d'infezione e zone di rifugio per lo scafoideo e dovrebbero perciò essere eliminati. Altrettanto, dovrebbe essere attuato nei confronti dei vigneti maggiormente colpiti, in cui si ritiene non più realizzabile e sicuramente antieconomica la bonifica.
LOTTA DIRETTA ED INDIRETTA
Lotta alle singole avversità (i fondamentali)
Una difesa effettuata separatamente per singole avversità prevederebbe una lotta a FD così composta nei suoi fondamentali: 1. Lotta insetticida contro il vettore, lo scafoideo (un trattamento, sappiamo, è obbligatorio, che diventano due nei vigneti a conduzione biologica e nei campi di piante madri) 2. Estirpo delle viti ammalate (che rappresentano un focolaio d'infezione). E una lotta agronomica a BN così composta nei suoi fondamentali: 1. Lotta indiretta al vettore (lo ialeste) mediante diserbi mirati e localizzati, in aprile e settembre, alle malerbe coinvolte (convolvolo e ortica, in primis), ospiti del cixiide e del fitoplasma 2. Eventuale inerbimento controllato di graminacee (non ospiti di BN e di ialeste) 3. Gestione delle viti ammalate, considerando che, allo stato attuale delle conoscenze, non sono focolaio d'infezione e vi è la possibilità del recovery (risanamento o remissione dei sintomi).
Lotta combinata (lo standard)
In base alle analisi di laboratorio, sappiamo che i due fitoplasmi sono presenti su tutto il territorio provinciale, anche nello stesso vigneto, anche nella stessa pianta. Quindi, chi può dire che in un dato vigneto non vi è FD? Allora le indicazioni di lotta non possono che combinare la lotta alle singole avversità e in modo precauzionale puntando al minimo rischio nel modo seguente: 1. Lotta insetticida contro lo scafoideo 2. Diserbi mirati e localizzati a convolvolo e ortica 3. Estirpo delle viti ammalate (possibili focolaio d'infezione).
Tali indicazioni hanno rappresentato in tutti questi anni lo standard di lotta ai Giallumi della vite in provincia di Reggio Emilia. Linea certamente drastica ed onerosa che serviva e in parte è riuscita ad arginare l'espansione delle due malattie e a limitare fortemente gli scoppi epidemici che altrove sono risultati devastanti per l'economia di importanti realtà viticole (vedi in Piemonte, Veneto e Oltrepo pavese).
L'evoluzione: la lotta articolata
Passato quindi un decennio di forte pressione nel contrasto alla malattia, nella situazione attuale non certo rosea, ma sicuramente favorevole, che potremmo definire di post-epidemia, si può cominciare a pensare di gestire la presenza dei giallumi in modo "ordinario", assumendo rischi che prima sarebbero stati troppo alti e stando però attenti a non abbassare del tutto la guardia. Da questo presupposto nasce una lotta articolata ai giallumi della vite che ha come suoi pilastri: 1. Il gradiente di diffusione degli agenti eziologici. La presenza dei due fitoplasmi in provincia di Reggio Emilia ha un gradiente di diffusione che è decrescente per FD e crescente per BN da nord a sud e da ovest ad est (tabella 1) 2. La remissione dei sintomi o risanamento (recovery). Il recovery, sappiamo, può essere spontaneo o indotto, con risultati discreti, dalla capitozzatura delle viti ammalate. Infatti, dalle prove effettuate negli anni scorsi su Ancellotta e Lambrusco salamino, abbiamo constatato che, sebbene vi siano differenze tra varietà e anche tra annate diverse, la capitozzatura bassa (effettuata, cioè, poco sopra l'innesto) fornisce le maggiori possibilità di remissione dei sintomi (ma anche un aggravio dei costi nella gestione della potatura) 3. L'assunzione di responsabilità del viticoltore in qualità di imprenditore (non esistendo più obbligo diretto all'estirpo delle piante sintomatiche). Fermo restando le altre azioni, nelle aree a minor o minima presenza di FD e del suo vettore, scommettendo sulla presenza di BN e sulle possibilità di recovery, l'imprenditore agricolo può mettere in atto una strategia di lotta articolata che preveda, in alternativa all'estirpo delle viti ammalate, la loro gestione: 1. Lotta insetticida contro scafoideo 2. Lotta indiretta a ialeste mediante diserbi mirati (in aprile e settembre) e localizzati a convolvolo e ortica e/o eventuale inerbimento controllato con miscugli di graminacee 3. Gestione delle viti ammalate: estirpo (come possibili focolai d'infezione) o in alternativa la capitozzatura bassa (poco sopra l'innesto) e successiva eliminazione delle viti capitozzate che ne ripresentassero i sintomi.
Lotta al vettore della FD
Scaphoideus titanus è una cicalina monovoltina e ampelofaga, ciò la rende "facilmente controllabile". La strategia di lotta chimica deve tener conto:
- della schiusura piuttosto scalare delle uova;
- del periodo d'incubazione del fitoplasma nella cicalina di 30-35 giorni, necessario perché lo scafoideo diventi a sua volta infettivo dopo aver assimilato il fitoplasma nell'atto trofico su piante infette
- che la lotta insetticida serve a contenere le popolazioni dei vettori, non ad estinguerle.
Con densità di popolazione molto basse (come nel reggiano) è possibile controllare il vettore della FD con un unico trattamento (posizionato indicativamente nell'ultima decade di giugno). In presenza di popolazioni significative del vettore e con epidemie in atto, sono consigliati due trattamenti insetticidi (il 2° da effettuare ca. 30 giorni dopo il 1° trattamento).
E' buona norma eseguire la spollonatura solo dopo il primo trattamento insetticida. Questo perché, vista la predilezione delle forme giovanili a vivere sulle parti basse della vegetazione, si potrebbe meglio colpire la cicalina dirigendo i getti dell'atomizzatore anche sui polloni ai piedi delle viti.
Gli insetticidi raccomandati per la lotta alla cicalina della flavescenza, in base anche alle decine di prove applicative da noi svolte negli anni, sono quelli indicati nei Disciplinari di produzione integrata e vanno posizionati in relazione alle loro specifiche modalità d' azione.
Nei vigneti a conduzione biologica, si consiglia di usare preferibilmente prodotti a base di piretro anche se addizionati con piperonilbutossido e di ripetere due-tre volte il trattamento ad intervalli di 5-7 giorni, trattando nelle ore serali ed acidificando l'acqua (pH 5-6).
Lotta al vettore di BN e agli ospiti erbacei
La lotta a ialeste (Hyalesthes obsoletus), per le sue caratteristiche (polifago e ospite occasionale della vite quando adulto, sfarfallamento molto scalare e forme giovanili sub-terricole), si attua con il contenimento delle erbe infestanti ospiti, presenti all'interno e all'esterno del vigneto. Pertanto, è necessario diserbare in modo specifico ortica e convolvolo, ospiti sia del vettore sia del fitoplasma.
I trattamenti diserbanti dovrebbero essere fatti in primavera e in autunno, quando si è in presenza delle sole forme giovanili terricole del vettore. Questo determinerebbe non solo l'eliminazione delle infestanti ma anche quella del vettore che si troverebbe impossibilitato a completare il ciclo.
Un importante accorgimento è quello di sfalciare quando non vi è il volo del vettore, in modo da non favorire le migrazioni sulla vite. Per questo motivo gli interventi in primavera, nella nostra provincia, dovrebbero essere eseguiti entro la prima decade di maggio. Un accorgimento nei vigneti all'impianto potrebbe essere la semina di graminacee.